LIBRI / RAGUSA RUGBY
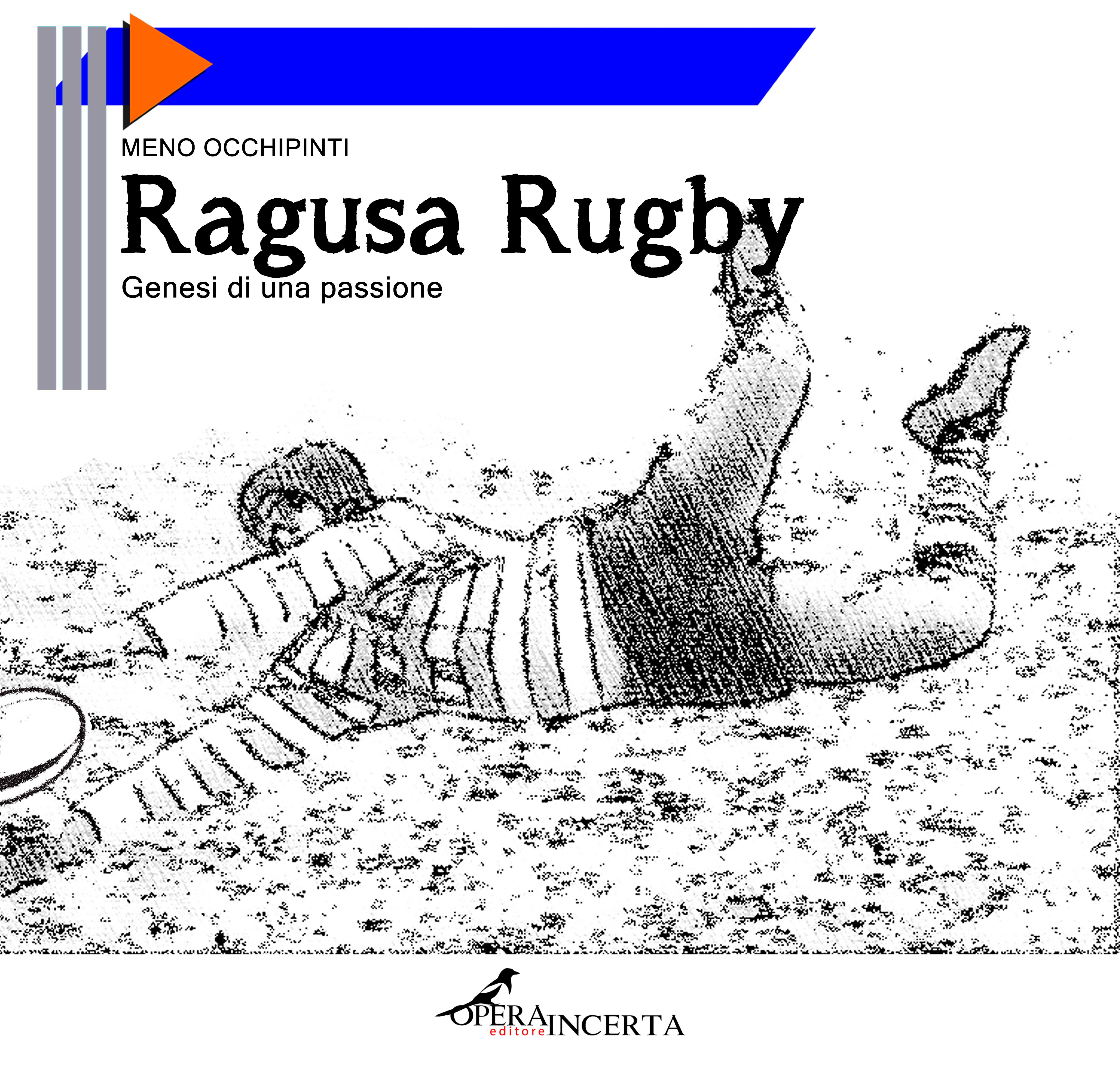
foto di copertina elaborata da Loretta Dalola | Prefazione di Gianni Papa
LA PREFAZIONE
È stato davvero un piacere aderire al cortese invito a scrivere “due righe” di prefazione per questo lavoro di ricerca, lungo, partecipato, attento, metodico e, per quanto possibile a chi in quegli anni “non c’era”, esaustivo.
Confesso che essendo stato costretto, per scriverle, ad aprire l'archivio della memoria e tirarne fuori molti vecchi files scampati agli spietati “cancella” imposti dall'età, all’inizio ho provato a fare resistenza passiva, fingendo (per paura, pudore o chissà che altro ancora) di non ricordare dove li avevo “sistemati”.
Il tentativo, patetico, è durato finché (prestissimo) il fascino dell’amarcord ha dispiegato tutto il suo suadente potere di attrattiva: da quel momento in poi non mi è rimasto che arrendermi al suo struggente sortilegio. Una resa dolcemente malinconica, perché sapevo che ognuno di quei files, vecchi ma già multimediali (con suoni, immagini, odori e sensazioni), avrebbe fatto un buchino nel guscio che per tanti anni li aveva custoditi e protetti e che mi avrebbe ferito: certo, una ferita piccola, ma non per questo indolore o rapida nel rimarginare.
Detto questo, coraggio: posso cominciare.
Sembra difficile crederlo, però il rugby “marca Pintaldi” con cui venni (per caso) a contatto nel 1969, il rugby dei “miei” anni (eravamo appena andati sulla luna, Ragusa era incredibilmente diversa e dove ora c’è un'intera città ci portavi la ragazza, “coperta” dall’amica) era romantico.
Sì, romantico: ti sentivi un pioniere, ti guardavano “strano” ma quasi ammirati, l’odore forte di sifcamina nello spogliatoio prima della partita era il legame complice che ci accomunava, esser riconosciuti in via Roma scaldava il cuore, partire al mattino per la trasferta era come partire per un’avventura.
Per i rugbisti storici il rugby era “lo sport”, isolato sulla torre d’avorio, ma non è che noi, nuovi arrivati, ci sentissimo migliori.
Diversi sì: e questo era bello e ci piaceva da matti, ripagandoci dell’acqua gelata a fine allenamenti (quando c’era), dei viaggi inscatolati come sardine nelle indimenticabili Peugeot “strapuntinate”, dei centimetri quadrati di pelle lasciati su terreni di gioco carta vetrata, delle scoppole degli avversari e di tutto il resto. Era bello e – ripeto – romantico.
Forse anche perché, nonostante fosse il dopo sessantotto, rimaneva un briciolo della vecchia, scanzonata goliardia e non si doveva ancora ripagare lo sponsor col ritorno in termini di risultati.
Continuò più o meno così finché Franco Pintaldi, padre e “patron” dell’idea ovale, oltre che giocatore, presidente che pensava, sceglieva, organizzava e decideva tutto, rimase a Ragusa.
Quando ottenne il trasferimento nella sua Catania, di punto in bianco “quelli di allora” dovettero decidere se smettere (non avendo di cosa vergognarsi) o continuare (senza conoscere le difficoltà del viaggio, quanto fosse distante il traguardo e, peggio di tutto, senza alcuna esperienza).
La decisione fu figlia della passione, ancora giovane ma già forte, dell’entusiasmo, di un pizzico (abbondante) di spensierata incoscienza e, credo anche, della mancanza di un’alternativa.
Piuttosto che affogare, si scelse di bere “intanto”, rimandando a dopo il tentativo di rendere l’acqua più limpida possibile.
Puntando su tre novità: dirigenza di soli giocatori, buoni rapporti (niente spocchia ma pari diritti) con gli altri sport cittadini e ricerca della massima visibilità (che, in sostanza, al tempo voleva qualche articolo sul giornale).
Iniziato il campionato grazie al piccolo prestito ricordato da Meno, subito notammo un dato di fatto gradito quanto inatteso: eravamo forti, tanto da poter perfino vincere il campionato. La miscela tra universitari, chi era ancora alle superiori, chi già lavorava duro, chi era vicino al quarto di secolo e chi aveva sedici anni appena, chi aveva viaggiato e chi non era mai neppure salito sul traghetto, chi aveva la macchina e chi nemmeno la patente, chi “con ragazza” e chi ancora senza barba, chi con padre e madre che non ostacolavano e chi con padre e madre “così il ragazzo non studia”, si stava rivelando riuscita, resistente al tempo e all’inesperienza, capace di attirare spettatori, più forte delle difficoltà (economiche innanzitutto, ma non solo) e vincente.
In quell’anno di serie D, si partiva di mattina presto su di un piccolo autobus che odorava di panini e scacce, prendendo la “superstrada” che finiva già prima di Licodia: mezza eternità e si arrivava, ci si spogliava (non sempre negli spogliatoi), si vinceva (tranne che a Milazzo, ma in quattordici) poi se possibile (di rado) ci si faceva la doccia e si risaliva sul piccolo autobus per tornare a casa.
Dopo il canonico “forza capo” all’autista, ci toccava di nuovo la micidiale Messina-Catania (l’autostrada non c’era), vissuta parlando tutti insieme, acciaccati compresi, della partita (vinta) tra sudore lavato in fretta, panini residui e aranciata, mentre i tanti posti vuoti all’andata erano preda degli ammaccati, sistemati “molto larghi” come meritato premio per le botte ricevute da smaltire. Al microfono del bussino le barzellette e le canzoni erano sempre le stesse, la stanchezza sembrava moltiplicare i chilometri e Ragusa sembrava non arrivare mai: però gli occhi erano allegri e la gioia per la vittoria faceva da meraviglioso anestetico per fatica e lividi.
Finimmo primi e affrontammo due spareggi promozione, entrambi vittoriosi. Il primo giocato a Messina, il secondo “addirittura” a Napoli: la carovana (con tanto di bandiera) iniziò la serie dei futuri infiniti viaggi in treno e nella notte in albergo a Caserta gli scherzi furono l’antidoto fatto in casa alla tensione.
Ritornammo prestissimo in una mattina di inizio maggio: per la prima volta la città aveva saputo della vittoria la sera prima, perché ci eravamo guadagnati l’onore della citazione nel “mitico” sport serale del Gazzettino di Sicilia. Onore incredibile in quel mondo senza tv e radio locali, internet, Facebook e compagnia bella.
Direi che a questo punto può bastare: per una prefazione, dilungarsi sarebbe poco rispettoso verso l’autore. Ma devo accennare almeno di sfuggita al dopo, l’anno della serie C: la promozione ci aveva consacrati tra le squadre della città, andavamo a vedere i colleghi del calcio e del basket, facevamo il tifo per loro ed eravamo ricambiati.
Entrati nel “giro grosso”, diventammo habitué del treno (allora si viaggiava solo così) Catania-Roma-Catania. Lasciavamo le macchine a Catania, una notte in treno all’andata, la partita e una notte in treno al ritorno: tutti, tranne Totò e Gino (studenti a Roma e L’Aquila) che ci attendevano alla stazione Termini. Le volte in cui la trasferta fu da ricordare dormimmo in albergo: capitò solo di rado, ma ogni volta fu bellissimo.
Nacque da questi viaggi, di solito ogni due settimane (i controllori ormai ci conoscevano e si limitavano a salutarci) la “tenace” leggenda dei giocatori costretti a dormire sulle reticelle dei bagagli e dei disagi e sacrifici quasi insostenibili: la verità, quella vera e senza la retorica è parecchio diversa. Senza dubbio i problemi erano tanti e di vario genere, e per venirne a capo imposero tanta buona volontà e tanto spirito di adattamento.
Però eravamo giovani, ci divertivamo e il diavolo era meno brutto di come sarebbe stato dipinto negli anni a venire: d’altronde, era più o meno lo stesso per quasi tutte le altre squadre cittadine di sport dilettantistici.
Fermo restando l’orgoglioso “distinguo” che noi andavamo tanto, tanto più lontano. E che partivamo sempre come minimo in venti.
Ora basta davvero: mi conservo gli altri files scaricati dei ricordi per un’altra prefazione. Se, come mi auguro, Meno avrà voglia di continuare la storia…